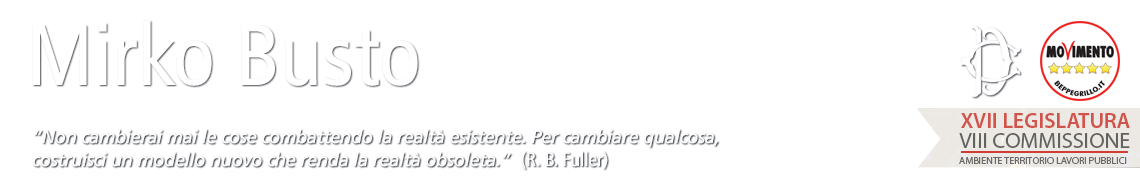Alternative al PIL
“Il Benessere di una nazione non può essere facilmente desunto da un indice del reddito nazionale”. Questa affermazione non è di qualche seguace della decrescita, ma di Simon Kuznets, l’inventore del Prodotto Interno Lordo (PIL). Del resto, chi meglio di lui poteva conoscere i limiti di un parametro come quello da lui creato, a partire appunto dalla sua capacità di misurare il benessere dei popoli o delle persone? Eppure, l’economista statunitense di origine bielorussa vinse nel 1971 il Nobel per l’economia proprio per “la sua interpretazione, empiricamente fondata, della crescita economica, che ha portato ad una nuova e più approfondita analisi della struttura sociale ed economica e del suo processo di sviluppo”. E la sua creatura domina ancora oggi le decisioni di politica economica in quasi ogni angolo del pianeta. Con conseguenze devastanti per la società, l’ambiente e, paradossalmente, per la stessa economia.
L’idea del PIL nacque negli anni ‘30, dopo la Grande guerra e la crisi economica del ’29 che portarono ad un crescente ruolo dei governi nell’economia. Era in pratica un momento molto particolare, checché se ne dica ben diverso da quello che viviamo ora – anche e soprattutto se si pensa al contesto ambientale e al consumo di risorse, allora ancor più ignorati. Erano tempi in cui la smania di industrializzazione e il desiderio di mostrare al mondo i propri muscoli sia a livello bellico che produttivo erano all’apice. E il PIL, in pratica, permetteva di conoscere quanto e in quali settori uno Stato producesse e quanto del reddito generato andasse a consumi, investimenti, esportazioni ecc. Nonostante le sue imperfezioni, una volta finita la Seconda guerra mondiale, questo indicatore ebbe sempre più importanza nelle politiche economiche di tutto il mondo, e fu adottato anche dalle grandi istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.
Misurando solo il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all’interno di un Paese in un certo intervallo di tempo, però, il PIL è un parametro e come tale dovrebbe essere trattato. Non significa volere necessariamente che questo scenda, ma tenere in considerazione che esso ci dice alcune cose, mentre non ce ne dice altre. Cresce quando girano soldi e merci, quando c’è una transazione economica, ma non quando si è in presenza, ad esempio, di un’azione di volontariato, di un dono fatto senza ricevere un pagamento in denaro, o di un gesto d’amore o di solidarietà. La critica forse più famosa in questo senso fu quella di Bob Kennedy, che già nel 1968 (tre mesi prima di essere assassinato) disse: “Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow Jones né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro istruzione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia e la solidità dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali, né dell’equità dei rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio né la nostra saggezza né la nostra conoscenza né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. Insomma, il PIL misura l’andamento economico di un Paese, ma non certo il suo benessere.
Non è un caso, dunque, se negli ultimi anni i tentativi di trovare un’alternativa al PIL siano stati numerosi, e a tratti anche interessanti. Molti studi e rapporti sono stati pubblicati negli ultimi tempi riguardo al fatto che ci sono altri fattori che devono essere presi in considerazione, quando si cerca di capire quanto i cittadini di una nazione si sentano felici o soddisfatti delle proprie vite. Come certe caratteristiche della sfera personale e sociale, o come l’impronta ecologica e la sostenibilità ambientale. Ottimi esempi sono stati “I limiti dello sviluppo”, redatto già nel lontano 1972 dal Club di Roma (titolo originale: “Limits to growth”), o l”Happy Planet Index”, studio internazionale realizzato dalla “New Economics Foundation” che, prendendo in esame 143 Paesi (nei quali risiede il 99% della popolazione planetaria), ha stilato una graduatoria mondiale della felicità percepita, focalizzandosi piuttosto che sulla misurazione della crescita o meno del PIL su punti quali aspettativa di vita, felicità ed impatto ambientale delle persone nelle diverse nazioni.
E che dire della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento”, con cui già nel 2010 addirittura le Istituzioni europee provarono a creare nuovi parametri che misurassero il benessere collettivo. Il più noto fra questi importanti studi è stato realizzato dalla Commissione coordinata dal premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz che ne ha presentato il rapporto finale insieme al premio Nobel per l’economia, Amartya Sen, e al noto economista francese Jean Paul Fitoussi. Questa Commissione è stata voluta agli inizi del 2008 dal governo SarKozy, che fin dall’inizio fornì forte appoggio e rilevanza politica, ed è stata formata da altri premi Nobel e illustri economisti, fra i quali Daniel Kahneman, Lord Nicholas Stern (si ricordi la “Stern Review on Climate Change” che ha calcolato i costi economici del cambiamento climatico) e l’italiano Enrico Giovannini dell’OECD. Persino l’Economist, generalmente un difensore del libero mercato, ha più volte ospitato un dibattito sull’utilità del PIL (GDP) concludendo che “si tratta di un pessimo indicatore per la misurazione del benessere”. E infine l’Ocse, altro colosso del tradizionalismo economico, sul cui sito web si legge: “Per una buona parte del ventesimo secolo si è dato per scontato che la crescita economica fosse sinonimo di progresso, cioè, che un aumento del PIL significasse una vita migliore per tutti. Ma ora il mondo comincia a riconoscere che non è così semplice. Nonostante livelli sostenuti di crescita economica, non siamo più soddisfatti della nostra vita (e tanto meno più felici) di cinquant’anni fa”.
C’è poi il “PIL modificato”, che tiene conto delle esternalità negative dell’attività economica, ad esempio sull’ambiente e sulla salute. E’ in pratica ciò su cui si basa il Genuine Progress Indicator (GPI, Indicatore di progresso autentico), elaborato a partire dagli anni ’90, che dà una valutazione delle esternalità negative in termini monetari, ottenendo così i dati con cui correggere il PIL. “Esistono però anche esternalità positive, ricorda Fabrizio Panebianco dell’Università di Milano-Bicocca: “Alcune attività (ad esempio la ricerca, o la bonifica di un’area inquinata) generano una produzione di beni contabilizzata nel PIL, ma hanno anche ricadute positive in termini di benessere di cui il PIL non tiene conto, per le stesse ragioni esposte nel caso delle esternalità negative. (È possibile assegnare un valore monetario anche alle esternalità positive. Su questa base è stato creato l’ISEW (Indice di benessere economico sostenibile), che cerca di correggere il PIL rispetto alle esternalità sia negative sia positive”.
Un parametro alternativo al PIL che ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi anni, almeno in Italia, è il Benessere Equo e Sostenibile (BES). Sviluppato dall’ISTAT e dal CNEL, anche questo indice si propone di valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. Il tutto tenendo presente indicatori relativi a disuguaglianza e sostenibilità. Il BES viene determinato a partire da 12 indicatori: salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione tempi di vita; benessere economico; relazioni sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; ricerca e innovazione; qualità dei servizi. Parlando di semplificazione, però, è facile intuire che dodici indicatori sono davvero molti. Anche troppi, secondo alcuni: motivo per cui il BES non può sperare di avere più successo del (semplice) PIL. Di questo avviso è ad esempio la succitata NEF, che ha recentemente lanciato cinque nuovi indicatori alternativi: buoni lavori, giustizia sociale, ambiente, benessere, salute. Cinque è decisamente meno di dodici. Secondo Karen Jeffrey, una delle autrici del rapporto NEF, il limite del BES è appunto questo: “Per i giornalisti, e anche per la gente comune, diventa troppo complicato esaminare centinaia di dati invece di uno soltanto”, spiega la ricercatrice inglese: “Per questo motivo il PIL, un’unica cifra, è così popolare. Perché semplifica le cose. Nel nostro rapporto siamo riusciti a ridurre le misure del benessere a 5 indicatori con i quali vogliamo raggiungere il grande pubblico”.
Le alternative possibili sono davvero numerose, e numerosi indici di benessere o di crescita alternativi al PIL che sono già stati proposti in questi ultimi anni: “L’indicatore di Progresso Reale (Genuine Progress Indicator- GPI), che cerca di misurare l’aumento della qualità della vita; l’Indice di Sviluppo Umano (HDI-Human Development Index), utilizzato dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite a partire dal 1993 per valutare la qualità della vita nei paesi membri; l’Indice di Sostenibilità Economica (Index of Sustainable Economic Welfare); il Subjective Well Being (SWB), vale a dire la percezione che gli individui hanno della propria vita e del grado di soddisfazione che provano per essa. Il SWB, ad esempio, in paesi come gli Stati Uniti o come il Giappone diminuisce o stenta a crescere nonostante il reddito pro-capite tenda a crescere, costituendo per alcuni economisti un paradosso, il ‘paradosso della felicità’, in quanto sono abituati a pensare al reddito come ad un buon indicatore di benessere”.
Se è giunto il tempo di trovare finalmente uno o più parametri che sostituiscano il dispotico e limitato PIL, è però ancora più importante cambiare il paradigma culturale dominante. Come? Abbandonando una volta per tutte l’illusione di una crescita economica infinita in un ambiente dalle risorse finite. Prima che sia troppo tardi.